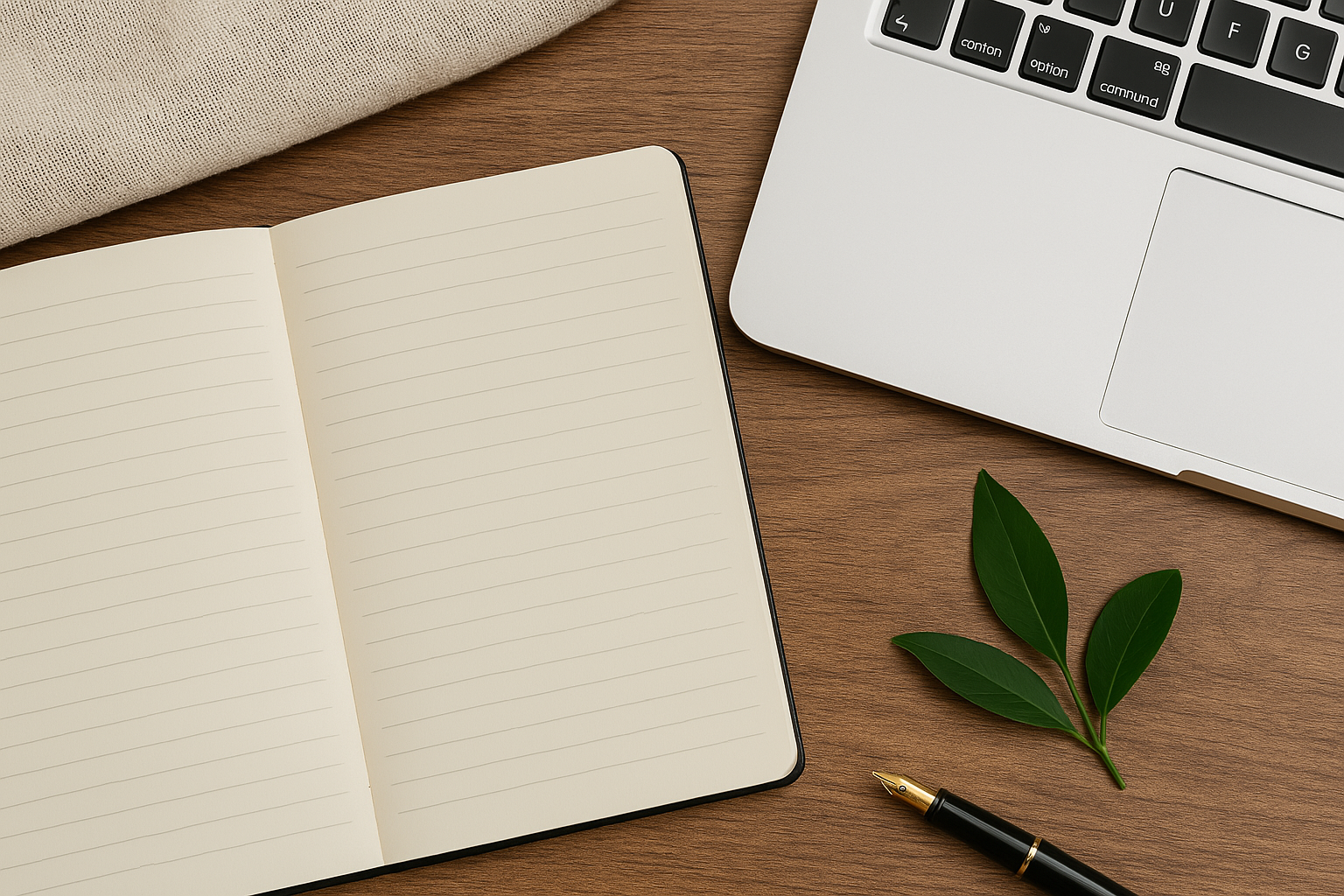Guida alle forme verbali (e non solo) nella narrazione
Quando si scrive narrativa, non si scelgono solo le parole, ma anche il tono con cui raccontare. E il tono passa, spesso, proprio dai verbi: alcune forme, anche se oggi poco usate nel parlato, portano con sé un sapore letterario, evocativo, narrativo.
Scrivere narrativa significa scegliere con consapevolezza come raccontare, e uno degli strumenti più potenti per farlo è proprio la forma verbale. Il tempo in cui si svolge il racconto non è un semplice dettaglio grammaticale, ma un elemento stilistico di grande peso.
Il tempo della narrazione: il passato remoto
Il passato remoto è il tempo narrativo per eccellenza nella lingua italiana. Viene usato per raccontare azioni concluse e distanziate dal presente, ed è particolarmente efficace nei testi letterari e nei racconti. Ha un ritmo più secco, diretto, capace di dare energia e compattezza all’azione.
Esempio:
“Si sedette accanto al camino e attese in silenzio.”
suona molto più narrativo e coinvolgente di:
“Si è seduto accanto al camino e ha aspettato in silenzio.”
Nel primo caso, ci immergiamo in una narrazione classica; nel secondo, percepiamo un tono più cronachistico, vicino al parlato quotidiano.
Forme verbali doppie: letteraria vs narrativa comune
Alcuni verbi italiani hanno due forme corrette al passato remoto: una più alta o letteraria, una più comune. Alcuni esempi sono:
sedé variante alta / sedette variante comune (dall’infinito sedere)
cadé / cadde (inf. cadere)
piacé (arcaico) / piacque (inf. piacere)
apparì / apparve (inf. apparire)
sparì / sparve (inf. sparire)
volé (arcaico) / volle (inf. volere)
Il presente narrativo: immediatezza e coinvolgimento
Anche il tempo presente può essere una scelta narrativa efficace. Pur essendo meno usato nella narrativa tradizionale, ha un potere particolare: dona immediatezza, fa sentire il lettore dentro l’azione, come se tutto accadesse sotto i suoi occhi, in tempo reale.
È usato spesso nei librogame, dove serve a coinvolgere direttamente il lettore in una modalità interattiva:
“Apri la porta ed entri nella stanza buia. Una figura ti osserva in silenzio.”
In altri casi, il tempo presente trova spazio in cornici narrative ben precise, come nei romanzi epistolari o nei diari personali, dove presente e futuro assumono una funzione narrativa forte, legata all’autenticità della voce interiore del personaggio.
Scegliere il tempo presente significa assumere una posizione stilistica chiara, diversa da quella del passato remoto, ma altrettanto potente. Non si tratta solo di “moda” o di comodità grammaticale, ma di uno strumento narrativo consapevole.
Anche alcuni sostantivi possono arricchire la narrazione se si scelgono varianti meno colloquiali. Alcuni esempi:
Seggiola per Sedia
Dimora per Casa
Figlio d’Uomo per Uomo
Fanciullo per Bambino
Timore per Paura
Compagno per Amico
Naturalmente, è bene usare queste parole con equilibrio: troppe tutte insieme rischiano di rendere il testo rigido. Ma scelte mirate possono dare colore e atmosfera al racconto.
Conclusione
Scrivere narrativa non è solo raccontare cosa succede, ma soprattutto come succede. Le forme verbali — insieme a scelte lessicali mirate — possono dare profondità, ritmo, stile al racconto.
Il passato remoto è la voce classica della narrazione italiana, ma non l’unica. Anche il presente può creare effetti potenti: immediatezza, interazione, intimità. L’importante è scegliere con intenzione, con consapevolezza, e non per abitudine.
Perché ogni tempo verbale è una lente diversa sulla storia. E un bravo narratore sa quando cambiare lente per ottenere l’effetto desiderato.