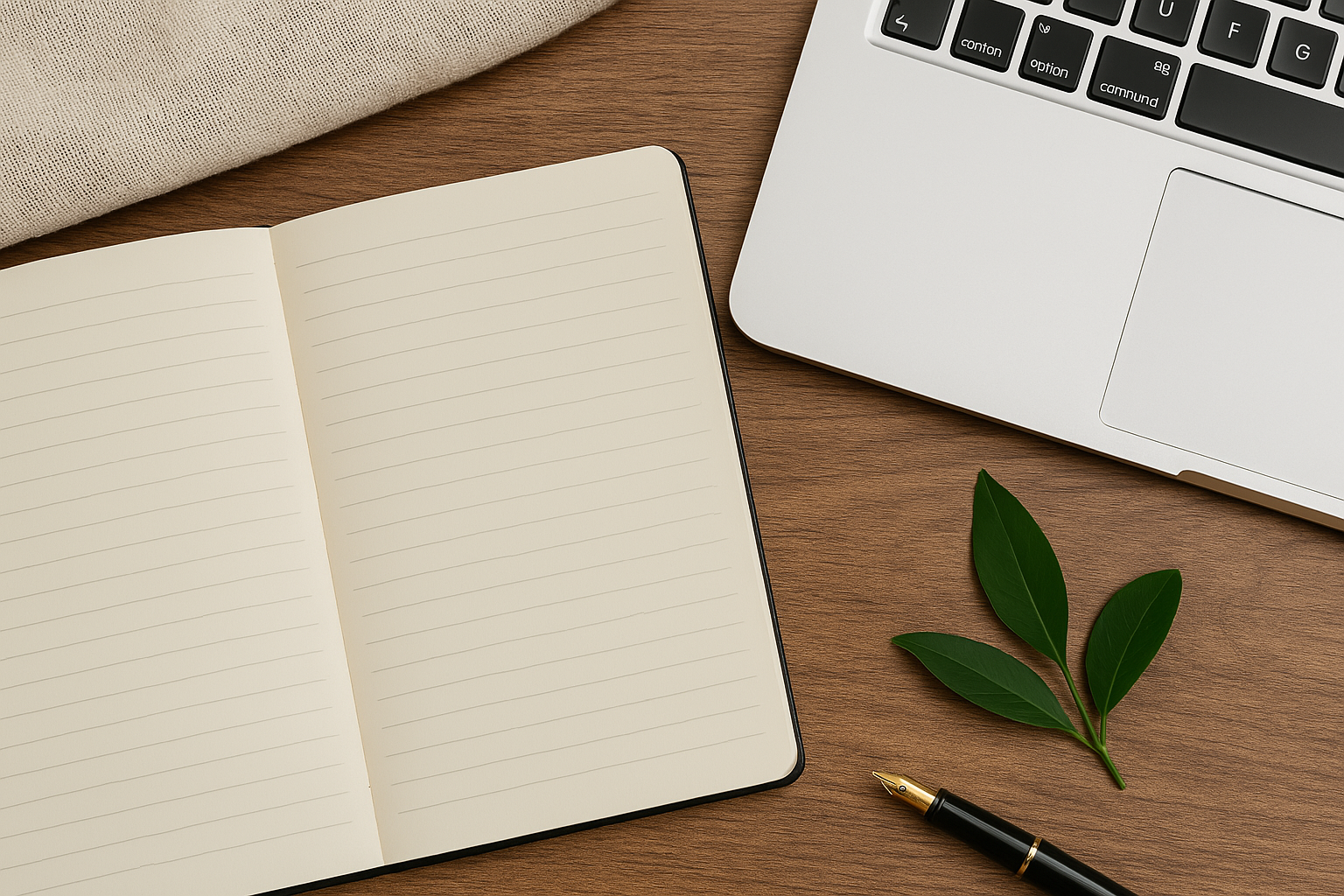Dalle radici antiche ai neologismi contemporanei, un percorso attraverso le dinamiche che trasformano l’italiano e ne custodiscono la memoria.
La lingua, in quanto organismo vivo, è il prodotto di un equilibrio sottile tra conservazione e cambiamento. Da un lato, le strutture linguistiche tendono a persistere nel tempo per garantire comprensione e continuità culturale; dall’altro, la lingua muta, si adatta, assorbe nuovi significati e forme. Questo doppio movimento è ciò che rende ogni idioma tanto radicato nella storia quanto proiettato nel futuro.
Il sostrato linguistico: voci del passato nei suoni del presente
Quando parliamo di sostrato linguistico, ci riferiamo a quelle tracce lasciate da lingue precedenti che, pur scomparse, hanno modellato la lingua dominante successiva. In Italia, ad esempio, molte caratteristiche dialettali derivano dalle lingue prelatine: etrusco, ligure, osco, per citarne alcune. Il sostrato ci ricorda che una lingua non nasce mai da zero, ma si costruisce su ciò che l’ha preceduta. Spesso ignoriamo che parole comuni, strutture sintattiche o fonemi atipici sono reliquie di idiomi antichi, sopravvissuti sotto la superficie. Ad esempio, la tendenza a usare la “e” aperta in toscano o la presenza della “b” al posto della “v” in alcune parlate meridionali (come “boca” invece di “voce”) possono essere spiegate con influenze sostratiche. Inoltre, parole italiane di uso comune come “guardia” e “guerra” derivano da radici germaniche (rispettivamente da wardōn e werra), introdotte durante le invasioni barbariche. Allo stesso modo, termini come “zucchero” (da sukkar), “albicocca” (da al-barqūq) e “cotone” (da qutn) testimoniano l’influsso del sostrato arabo, soprattutto attraverso i contatti culturali e commerciali con il mondo islamico nel Medioevo.
Cambiamento linguistico e cambiamento culturale: un binomio non sempre perfettamente allineato
Se è vero che i mutamenti culturali influenzano il linguaggio (basti pensare al lessico digitale entrato nella nostra quotidianità: “cliccare”, “postare”, “scrollare”), non è altrettanto vero che ogni cambiamento linguistico implichi una trasformazione culturale corrispondente. Alcuni mutamenti avvengono per motivi puramente interni alla lingua: semplificazioni fonetiche, analogie morfologiche, usi consolidati nel parlato. Ad esempio, l’uso crescente della forma “gli” al posto di “le” nei pronomi (“gli ho detto” riferito a una donna) nasce da una spinta alla semplificazione sintattica più che da un mutamento ideologico. Altre volte, invece, è la cultura che cambia più rapidamente della lingua, la quale si trova a rincorrere nuovi significati e necessità espressive.
Si può congelare una lingua? La tentazione del tempo immobile
Tentativi di congelamento linguistico ci sono stati, basti pensare all’italiano letterario fissato dai grammatici sul modello di Petrarca e Manzoni. Ma ogni tentativo di cristallizzazione si scontra con l’uso reale della lingua, che continua a evolversi nei contesti orali e scritti quotidiani. Le accademie linguistiche possono regolamentare, consigliare, proporre norme, ma non arrestare il flusso vitale del linguaggio. Conservare una lingua ha senso nella misura in cui si vuole proteggere un patrimonio culturale, ma impedirne l’evoluzione equivale a negare la sua natura dinamica. Ne è un esempio il latino ecclesiastico, mantenuto stabile per secoli a scopo liturgico, ma ormai distante dall’uso quotidiano e accessibile solo a pochi.
L’illusione dei grammatici e il valore degli errori
I grammatici hanno spesso inseguito l’ideale di una lingua pura, corretta, perfetta. Ma questa visione è un’illusione. La storia linguistica è fatta di deviazioni, usi scorrette considerati poi standard, innovazioni nate da errori. Gli errori stessi sono spesso la chiave per comprendere come una lingua si sia trasformata: ciò che oggi è norma, ieri poteva essere sbaglio. Ad esempio, parole come “telefono” o “automobile” inizialmente contestate per la loro composizione greco-latina sono oggi perfettamente accettate. La grammatica non è un codice immutabile, ma una fotografia in movimento della lingua in un dato momento.
In conclusione
la lingua non è una cartografia immobile, ma un paesaggio in costante mutamento, segnato da strati antichi, fratture culturali, rinnovamenti continui. Esplorarla significa riconoscere in essa non solo un mezzo di comunicazione, ma un archivio vivente della storia umana.
📚Riferimenti bibliografici per approfondire
- Serianni, L. Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria. (UTET, 1989)
- Berruto, G. Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo. (Carocci, 2012)
- Castellani, A. Saggi di linguistica e filologia italiana. (Edizioni dell’Ateneo, 1980).
- Migliorini, B. Storia della lingua italiana. (Bompiani, 1963)
- Simone, R. Fondamenti di linguistica. (Laterza, 2000)
- De Mauro, T. Storia linguistica dell’Italia unita. (Laterza, 2005)